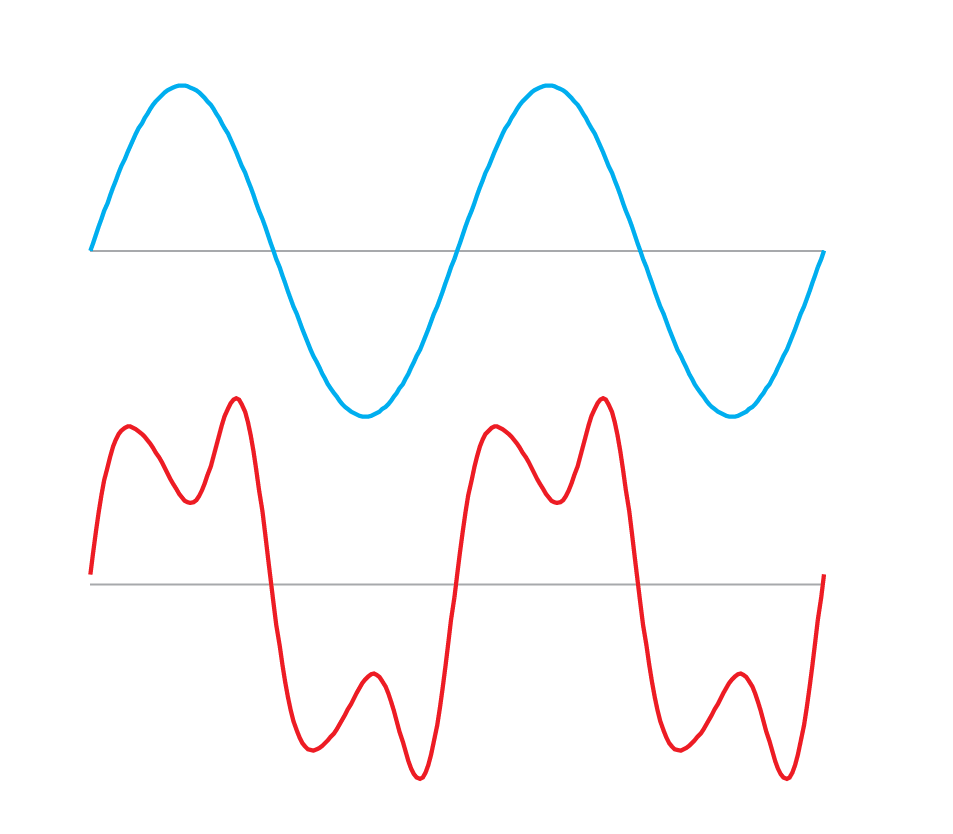1. Contestualizzazione Storica e Fondamenti Normativi
L’evoluzione della disciplina relativa all’installazione di impianti all’interno degli edifici in Italia rappresenta un percorso di progressiva professionalizzazione e tutela della sicurezza. Prima dell’introduzione di una normativa specifica, circa 30 anni fa, l’installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, gas e altri sistemi tecnologici non richiedeva il possesso di particolari requisiti tecnico-professionali. Il mercato era lasciato all’autoselezione, e la realizzazione di un impianto poteva persino essere affidata al “fai da te” da parte dei proprietari. Questa situazione di potenziale insicurezza ha reso necessaria una regolamentazione strutturata.
La Legge 5 marzo 1990, n. 46 ha segnato una vera e propria rivoluzione in questo campo. Essa ha stabilito per la prima volta i requisiti professionali necessari per le imprese che intendevano operare nell’installazione degli impianti. Ha inoltre introdotto l’obbligo di progetto per gli impianti che superavano determinati limiti dimensionali e, soprattutto, ha reso obbligatoria per tutti gli impianti la Dichiarazione di Conformità (DiCo), un documento fondamentale per certificare che l’opera fosse stata realizzata a “regola d’arte”. Questa dichiarazione è diventata presto un requisito indispensabile per ottenere certificati di agibilità e abitabilità per gli immobili.
Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (abrogando la Legge 46/90), ha rappresentato un ulteriore passo avanti, riorganizzando la materia e mantenendo i principi cardine della normativa precedente. Il D.M. 37/08 ha esteso l’ambito di applicazione a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Ha ridefinito la classificazione degli impianti in sette categorie principali, dalla produzione di energia elettrica (lettera A) agli impianti di protezione antincendio (lettera G). Un elemento chiave introdotto dal decreto è il concetto di “punto di consegna della fornitura,” dal quale la normativa inizia a essere applicata. Le recenti modifiche apportate dal
D.M. 192/22 hanno ulteriormente ampliato questa definizione, includendo esplicitamente anche i “punti di immissione” per i segnali e le reti dati, riconoscendo la crescente importanza delle infrastrutture digitali negli edifici moderni.
2. L’Obbligo di Progetto e le Sue Soglie Dimensionali
Una delle disposizioni più significative del D.M. 37/08 riguarda l’obbligo di redigere un progetto per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento degli impianti. Un’interpretazione superficiale potrebbe suggerire che questo obbligo sia limitato solo a casi complessi, ma la normativa stabilisce che il progetto è sempre obbligatorio, con l’eccezione degli impianti totalmente all’aperto o nei cantieri edili. La distinzione fondamentale, invece, risiede nella figura professionale che ha la responsabilità di redigere tale progetto: in alcuni casi può essere il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, in altri è tassativamente richiesto un professionista iscritto all’albo (come un ingegnere o un perito).
Il quadro normativo stabilisce soglie precise per determinare se la redazione del progetto debba essere affidata a un professionista abilitato. Queste soglie, elencate all’Articolo 5, comma 2, del D.M. 37/08, tengono conto non solo delle dimensioni e della potenza dell’impianto, ma anche della sua destinazione d’uso e dei rischi specifici associati.
2.1. Soglie per l’Obbligo di Progetto da Professionista
- Impianti in unità immobiliari ad uso abitativo: Il progetto di un professionista è necessario se l’unità ha una superficie superiore a 400 metri quadrati o una potenza impegnata superiore a 6 kW. L’obbligo sussiste anche se l’unità comprende una centrale termica a gas con potenza superiore a 35 kW, locali adibiti ad uso medico, o se ha una classe di compartimento antincendio uguale o superiore a 30.
- Impianti in servizi condominiali: Un progetto professionale è richiesto per impianti con potenza impegnata superiore a 6 kW, per quelli che servono una centrale termica a gas con potenza superiore a 35 kW, o una autorimessa condominiale con capienza superiore a 9 veicoli che non si affacci su uno spazio a cielo libero. L’obbligo scatta anche se la classe di compartimento antincendio è superiore a 30 o se l’edificio ha un’altezza di gronda superiore a 24 metri.
- Impianti in locali adibiti ad attività produttive, commerciali e del terziario: È sempre richiesto il progetto di un professionista in presenza di una cabina di trasformazione propria o se la superficie supera i 200 metri quadrati. L’obbligo è esteso a tutti gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio.
La complessità di queste interazioni rende fondamentale per il professionista non limitarsi alla conoscenza del D.M. 37/08 in isolamento. L’obbligo di progetto, ad esempio, può essere innescato da normative esterne, come quelle di prevenzione incendi. Per gli impianti di protezione antincendio (lettera G), il progetto è obbligatorio se l’impianto è inserito in un’attività soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), o se il numero di idranti è pari o superiore a 4, o se il numero di apparecchi di rilevamento è pari o superiore a 10. Per individuare le attività soggette a CPI, è necessario consultare il
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che classifica le attività a rischio in base a parametri come la tipologia di materiali, la superficie o il numero di occupanti, come le autorimesse con superficie superiore a 300 metri quadrati. Questo dimostra che la progettazione “a regola d’arte” richiede un approccio integrato e una profonda comprensione delle normative interconnesse. Un’omissione in questo senso non solo produce un impianto non conforme, ma espone a pesanti sanzioni.
3. Le Riforme del D.M. 37/08: L’Impatto del D.M. 192/22
L’articolo originale, sebbene utile, non riflette le dinamiche di un mercato impiantistico in rapida evoluzione tecnologica. Il D.M. 37/08, originariamente focalizzato sugli impianti energetici tradizionali, non copriva adeguatamente le nuove esigenze legate alla trasmissione e gestione di segnali e dati.
Per colmare questa lacuna, è intervenuto il Decreto Ministeriale 29 settembre 2022, n. 192, in vigore dal 28 dicembre 2022, che ha modificato alcuni articoli del D.M. 37/08. Queste modifiche non sono di natura meramente terminologica, ma segnano un adeguamento cruciale del quadro normativo italiano agli standard europei e alle esigenze di un’economia sempre più digitalizzata.
3.1. La Nuova Definizione della Lettera B
La modifica più significativa riguarda la definizione degli “impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere” (Lettera B). La nuova formulazione è molto più dettagliata e specifica, includendo: “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti”. Questo aggiornamento normativo eleva gli impianti dati e di comunicazione al pari di quelli elettrici o idraulici in termini di importanza e requisiti di conformità. È una risposta diretta alla sfida del “digital divide”.
3.2. L’Introduzione dell’Articolo 5-bis
Un’altra novità fondamentale è l’aggiunta dell’Articolo 5-bis, che impone specifici adempimenti al tecnico abilitato. Questo articolo rende il responsabile tecnico dell’impresa installatrice responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di “infrastruttura fisica multiservizio passiva”. Non si tratta più solo di installare cavi, ma di prevedere canalizzazioni, spazi e accessi che possano ospitare le future evoluzioni tecnologiche. Al termine dei lavori, il responsabile deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto in base alle guide CEI pertinenti, attestando la realizzazione “a regola d’arte” anche per l’infrastruttura passiva.
3.3. Il Nesso tra DiCo e Agibilità
Un’implicazione pratica di queste modifiche è che la Dichiarazione di Conformità, già requisito fondamentale, viene espressamente confermata come documento necessario per la presentazione della “segnalazione certificata di agibilità” (ex-certificato di agibilità). Questo passaggio integra la conformità impiantistica nel processo di certificazione urbanistica, rendendo la corretta esecuzione e documentazione un elemento imprescindibile per la commerciabilità e l’uso legale di un immobile. La mancata produzione della DiCo può portare a pesanti sanzioni e persino alla sospensione della fornitura di servizi essenziali.
4. La Guida CEI 0-2 e i Livelli di Progettazione nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
L’articolo di partenza fa riferimento alla Guida CEI 0-2 e alla Legge Merloni Bis (L. 216/95) per definire i livelli di progettazione. Tuttavia, questo quadro normativo è superato. Il riferimento alla Legge Merloni Bis è obsoleto, in quanto essa è stata abrogata e sostituita da successivi codici dei contratti pubblici. L’attuale riferimento normativo in materia di appalti pubblici è il
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
In questo contesto in evoluzione, è fondamentale comprendere il ruolo e il valore delle guide tecniche. A differenza delle “Norme” CEI, che definiscono le condizioni sufficienti per l’esecuzione a regola d’arte di un impianto e hanno valore vincolante, le “Guide” CEI (come la CEI 0-2) hanno un valore orientativo e non prescrittivo. Ciononostante, il D.M. 37/08 stesso stabilisce che un progetto elaborato in conformità alle norme e guide CEI si considera redatto secondo la regola dell’arte.
La nuova edizione della Guida CEI 0-2:2025 è stata aggiornata per allinearsi al D.Lgs. 36/2023. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha semplificato i livelli di progettazione, passando da una struttura a tre a una a
due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica costituisce il primo livello e ha lo scopo di individuare la migliore soluzione che offra il miglior rapporto costi/benefici per la collettività. Comprende studi preliminari e la definizione delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell’opera.
Il progetto esecutivo è il secondo livello, che sviluppa il progetto di fattibilità in ogni minimo dettaglio. Esso deve identificare ogni elemento in termini di forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, ed essere corredato da un piano di manutenzione che copra l’intero ciclo di vita dell’opera.
Per gli appalti privati, sebbene non vi sia l’obbligo di seguire formalmente questa struttura, la Guida CEI 0-2:2025 fornisce un modello di riferimento autorevole e riconosciuto per la redazione della documentazione di progetto.
Tabella 1: Confronto tra i Livelli di Progettazione
| Nomenclatura Obsoleta (Legge Merloni Bis) | Nomenclatura Attuale (D.Lgs. 36/2023) | Note e Corrispondenze |
| Progetto Preliminare | Non più previsto | La fase preliminare di analisi è inglobata nel nuovo progetto di fattibilità tecnico-economica. |
| Progetto Definitivo | Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica | Fasi di sviluppo progettuale con contenuti più approfonditi rispetto al precedente “definitivo”. |
| Progetto Esecutivo | Progetto Esecutivo | Mantiene il ruolo di dettaglio massimo per la realizzazione dell’opera. |